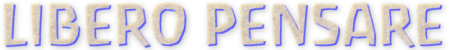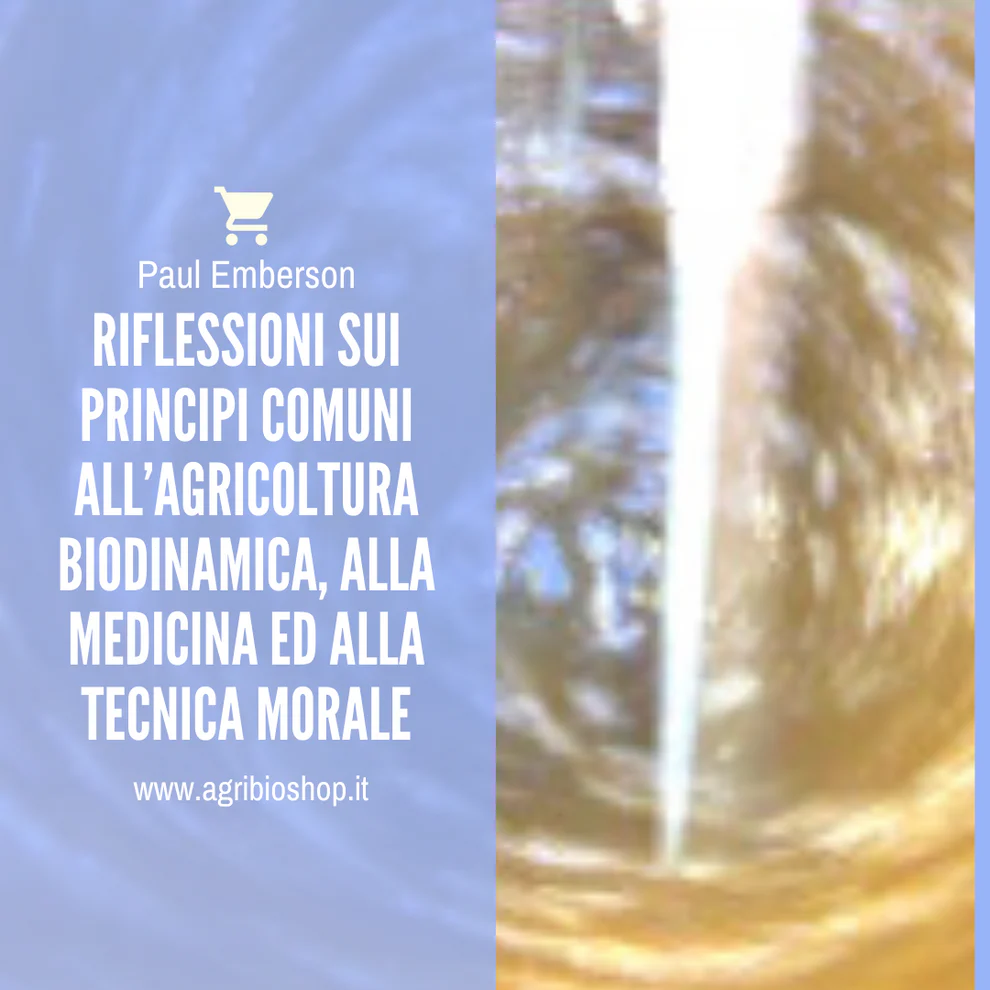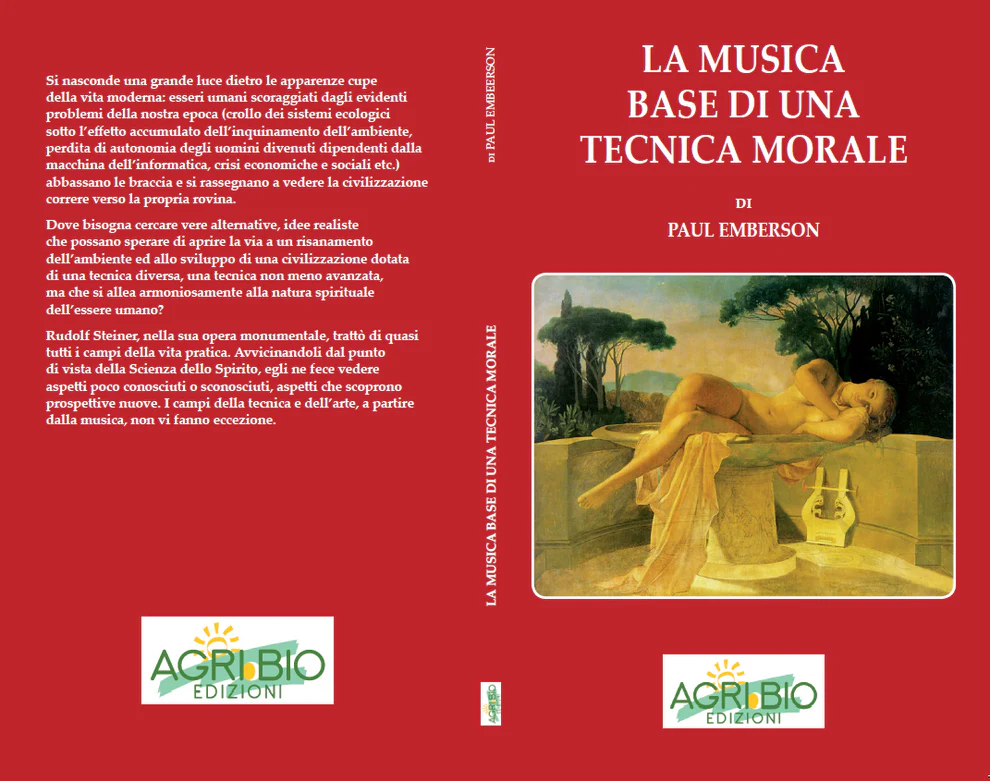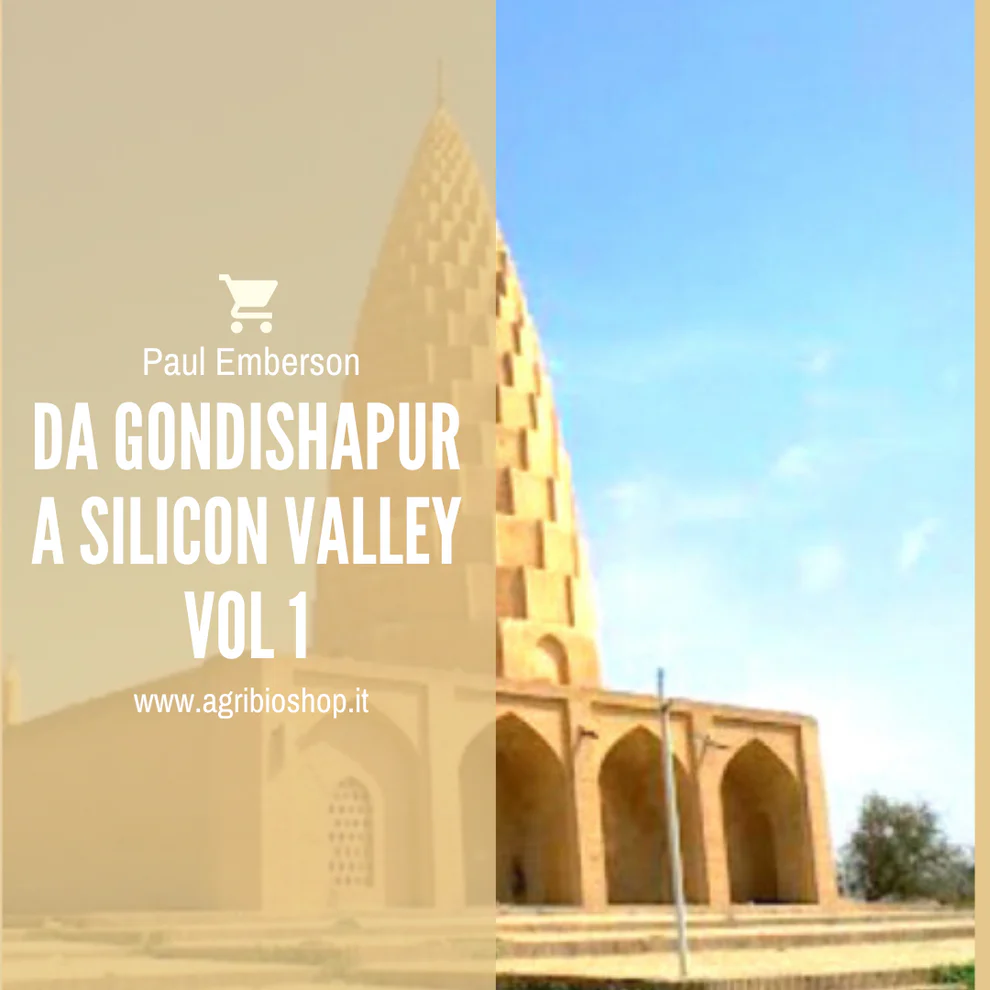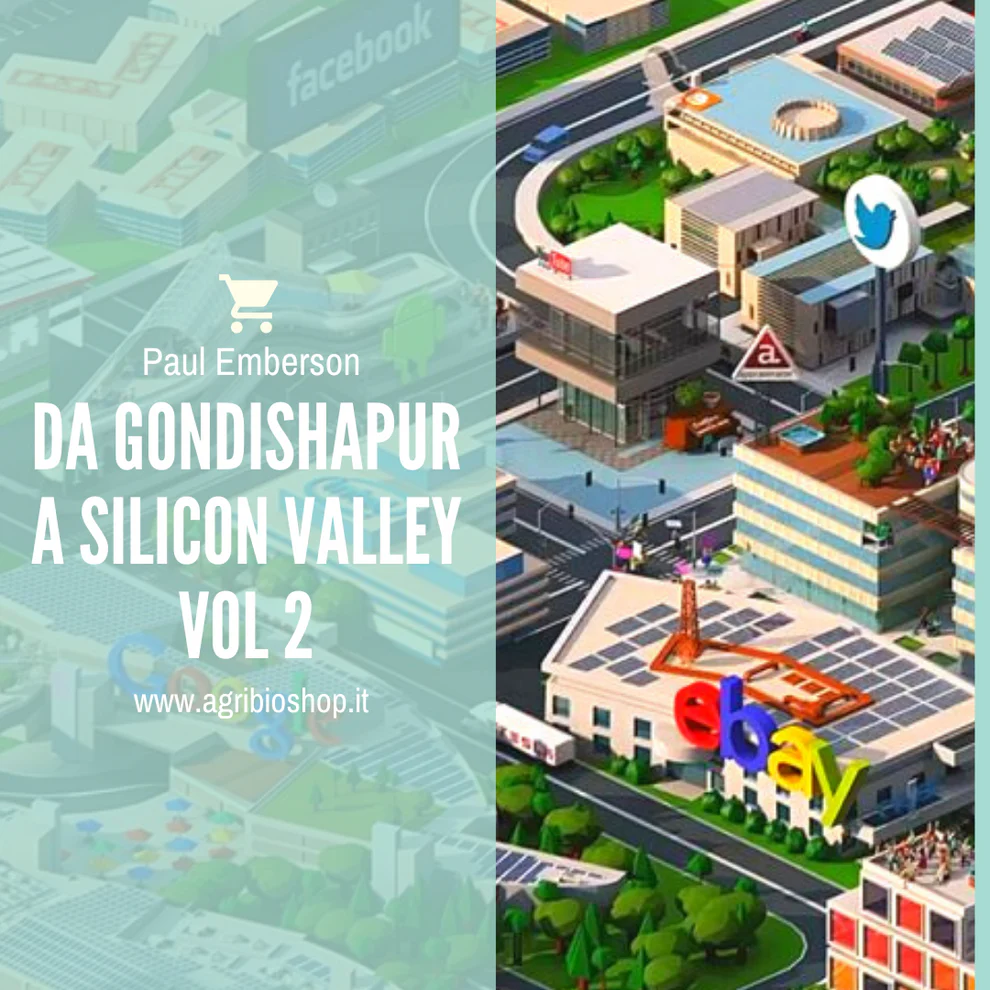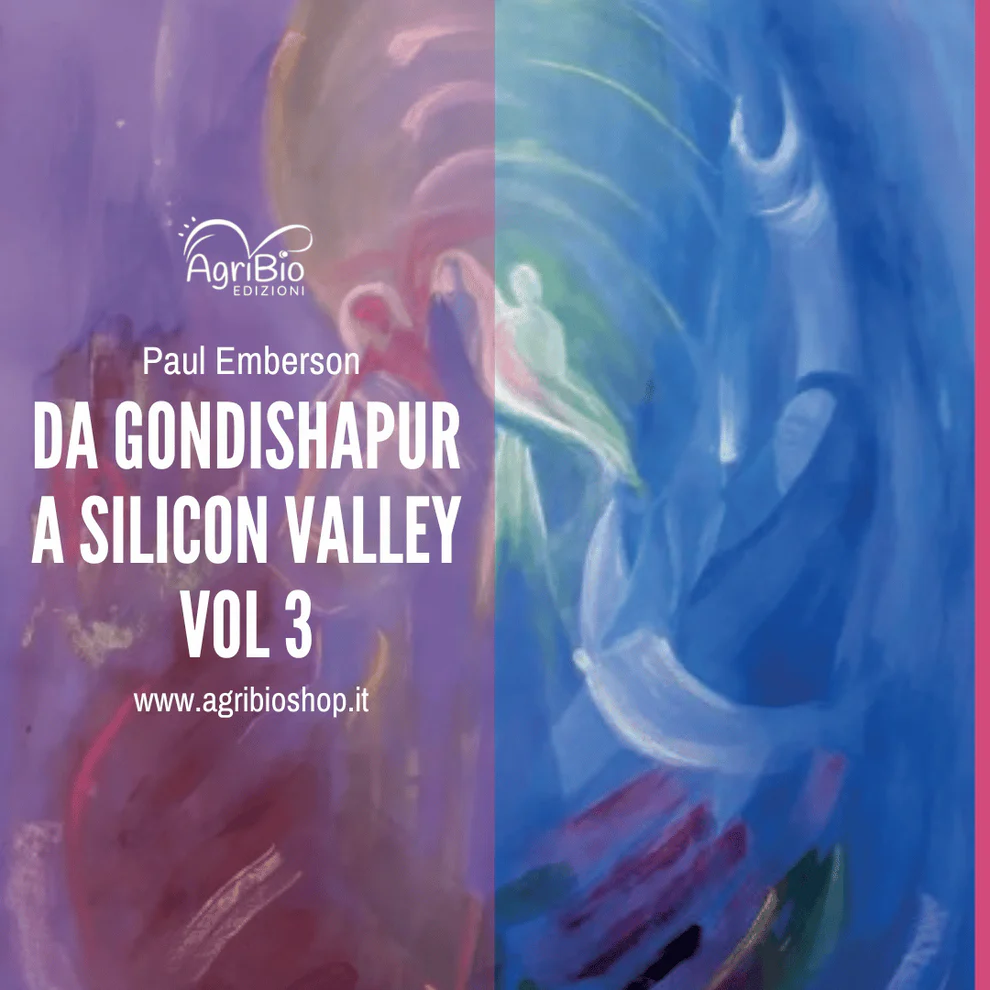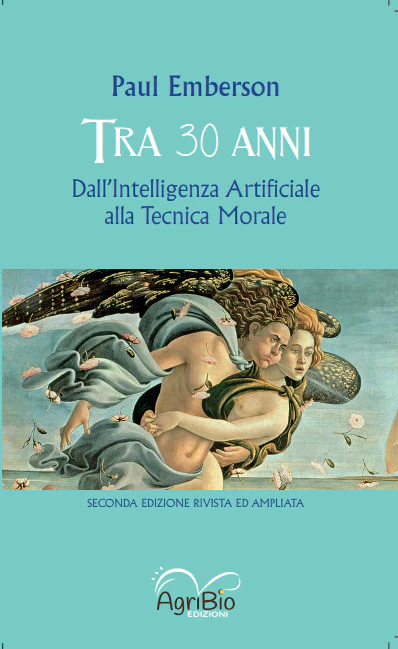Di Tarik Cyril Amar
I negoziati di pace in Ucraina dimostrano che Mosca vive nel mondo reale. L’Occidente, invece, non proprio.
Sotto alcuni aspetti importanti che i guerrieri dell’informazione occidentali amano ignorare, la Russia e l’Occidente sono piuttosto simili. Come l’Occidente, la Russia ha uno Stato tipicamente moderno, anche se oggi funziona molto meglio delle sue controparti occidentali.
L’economia russa è capitalista come quasi ovunque nel mondo, anche se lo Stato russo – proprio perché funziona meglio – ha riaffermato il controllo sui ricchi, mentre l’Occidente, malato di neoliberismo, lascia che questi dominino e danneggino gli interessi nazionali. Questo è uno dei motivi, tra l’altro, per cui la Russia ha resistito a una guerra economica occidentale senza precedenti e ha un complesso militare-industriale molto più efficace di quello occidentale.

Infine, pur estendendosi tra Europa e Asia, la Russia è anche una forza importante all’interno di quella specifica tradizione culturale che associamo all’Europa, o più in generale all’Occidente, dai romanzi ai conservatori classici.
Tuttavia, sotto altri aspetti, esistono differenze fondamentali tra la Russia e l’Occidente. Dimentichiamo per un momento i soliti sospetti (l’ortodossia russa contro il resto, per esempio, o le solite speculazioni sullo spazio, il clima e la mentalità). Cerchiamo invece di essere concreti e molto contemporanei: chiediamoci quali sono le differenze più importanti per trovare (o meno) una pace valida per il conflitto in Ucraina. Emergono allora due cose, una ovvia e l’altra un po’ meno.
Ciò che è facile da individuare è che la Russia è unita e l’Occidente no. In parte, ciò è semplicemente dovuto al fatto che Mosca governa un solo Paese, mentre Washington, capitale de facto dell’Occidente come entità geopolitica, governa – e sfrutta in modo sempre più crudele – un complicato impero esterno di Stati-nazione formalmente indipendenti che sono di fatto suoi clienti, satelliti e vassalli.
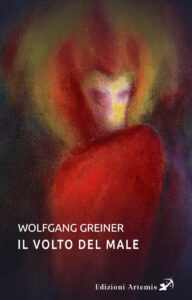
Mentre gli Stati Uniti esercitano un grande potere brutale sul loro dominio, in realtà quest’ultimo è potenzialmente divisibile come ogni impero precedente. Se pensate che la semplice affermazione dell’unità e del controllo equivalga alla realtà, chiedete ai sovietici quale fortuna hanno avuto con questa idea. Solo che non potete, perché un giorno c’erano e il giorno dopo, come per magia, non c’erano più.
Ciò che è più difficile da notare, ma che una volta notato non si può più ignorare, è che gli establishment politici della Russia e dell’Occidente hanno ora modelli di apprendimento fondamentalmente diversi.
In breve, quello della Russia è normale in quanto ha una curva di apprendimento con una bella inclinazione verso l’alto: ecco perché i suoi avversari trovano impossibile ingannarlo su larga scala, come è successo alla fine degli anni ’80 e per gran parte degli anni ’90.
L’attuale modello di apprendimento delle élite occidentali, in particolare europee, è invece molto insolito: forma, in effetti, un cerchio piatto e chiuso. Su questa traiettoria, le cose sembrano muoversi, ma in realtà non cambiano mai.
L’attuale stato dei tentativi di porre fine al conflitto in Ucraina attraverso negoziati e compromessi illustra perfettamente questa differenza. Infatti, sia la Russia che l’Occidente stanno mostrando in modo esemplare i rispettivi modelli di apprendimento o, nel caso dell’Occidente, di non apprendimento.
Da parte russa, le dure lezioni della sistematica malafede occidentale – dalle promesse di non espansione della NATO alle Minsk II – sono state pienamente assimilate. Di conseguenza, Mosca, pur essendo aperta al dialogo e a una soluzione basata su un accordo realistico, non commette l’errore di lasciarsi influenzare dalle emozioni, dalle speranze e dalle vibrazioni momentanee (le “vibrazioni dell’Alaska”, per esempio), come è successo alla Russia (e prima ancora all’Unione Sovietica) alla fine della Guerra Fredda, con conseguenze estremamente dolorose.
In concreto, ciò significa che la leadership russa ha chiarito che, dopo il vertice dell’Alaska come prima, non farà concessioni sugli obiettivi chiave. Ad esempio, Mosca non accetterà l’idea che l’Ucraina entri a far parte della NATO, nemmeno con un’altra denominazione. Allo stesso modo, non tollererà la presenza di truppe dei paesi della NATO nell’Ucraina del dopoguerra e non rinuncerà a garantire i diritti dei russofoni in Ucraina. Anche i tentativi piuttosto sciocchi di fare pressione sul Cremlino affinché conceda incontri prematuri con il leader ucraino Vladimir Zelensky, ormai alla fine del suo mandato, non hanno portato a nulla.
Ci sono osservatori occidentali immuni alla propaganda occidentale che valutano la Russia in modo equo. Alcuni di loro hanno recentemente espresso preoccupazione che Mosca possa cadere nelle trappole occidentali, come è successo alla fine della Guerra Fredda o nel 2015, quando la Russia ha accettato l’accordo di Minsk II, che l’Occidente e l’Ucraina hanno poi violato. Tuttavia, la leadership russa non mostra alcun segno di volerlo fare questa volta.
L’Occidente, invece, è bloccato nelle sue abitudini. Almeno nel suo insieme, sembra non aver imparato nulla dal feroce fallimento sia della sua strategia post-guerra fredda di espansione basata sull’inganno, sia del suo recente tentativo di eliminare la Russia come grande potenza attraverso una guerra per procura che utilizza l’Ucraina. La NATO è davvero kaputt, ma non se ne accorge.
Il segno più evidente che l’Occidente non ha ancora imparato la lezione è la sua persistente abitudine all’auto-diplomazia. L’Occidente è strano in quanto conduce la maggior parte dei suoi negoziati più intensi e appassionanti con se stesso. Si potrebbe pensare che ciò sia dovuto al fatto che l’Occidente è – strutturalmente – disunito, ma in realtà questa non è la vera ragione di questa abitudine narcisistica.
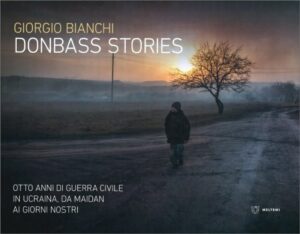
In realtà, la ragione di questo rifiuto autodistruttivo di affrontare la realtà è un’altra. Si tratta di un senso di superiorità profondo, del tutto fuori luogo e patologicamente indiscutibile. È come se l’Occidente fosse così potente da non doversi preoccupare di ciò che gli altri hanno da dire, ma solo del proprio soliloquio. Una fantasia assurda e altamente dannosa.
Si pensi alla cosiddetta “Coalizione dei volenterosi”, in sostanza un raggruppamento ad hoc di Stati per lo più europei (il Canada fa il Canada e non riesce a decidere) che sembrano incapaci di smettere di pianificare – con qualsiasi grado di sincerità – di inviare in qualche modo le loro truppe nell’Ucraina del dopoguerra, anche se solo con un “sostegno” statunitense che nessuno può definire in modo plausibile.
Seguite semplicemente i dibattiti occidentali e i media mainstream su questo sforzo confuso e in corso e vi sarà difficile persino notare un fatto piuttosto importante: la risposta della Russia a qualsiasi piano di questo tipo è un no molto netto. Eppure l’Occidente continua con il suo monologo geopolitico interiore: discutendo all’infinito di una cosa che – se i suoi leader ascoltassero davvero le loro controparti russe – saprebbero che non può essere realizzata. Perché insistere nel realizzarlo significa che Mosca non si accontenterà, ma continuerà a combattere e a vincere.
Questa potrebbe, naturalmente, essere la vera intenzione dell’Occidente: creare un motivo per rompere l’accordo. Ma se è così, allora la domanda successiva è perché gli Stati Uniti tollerano questa operazione di stallo e sabotaggio da parte dei loro vassalli europei.
Ci sono tre possibili risposte a questa domanda: o gli Stati Uniti stanno già segretamente pianificando di scavalcare i loro dipendenti europei e quindi non si preoccupano di come questi ultimi si tengono occupati con le loro fantasie. Oppure Washington è ancora cieca di fronte alla realtà quanto gli europei. Oppure, infine, Trump e il suo team credono di poter usare le continue chiacchiere degli europei sulla loro coalizione senza futuro come una sorta di leva nei negoziati con Mosca.
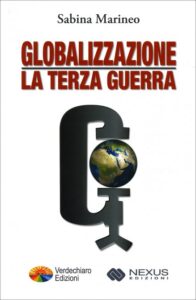
Di queste tre posizioni americane, solo una sarebbe realistica e produttiva: la prima. Le altre due significherebbero che Washington è incapace di imparare quanto l’Europa, perché un tentativo degli Stati Uniti di usare i discorsi europei come una sorta di bluff per esercitare pressione sulla Russia segnalerebbe che il team di Trump non ha fatto i conti con la determinazione della Russia a non concedere obiettivi di guerra importanti mentre vince sul campo di battaglia.
Si potrebbero aggiungere altri esempi. Ad esempio, le dichiarazioni incoerenti di Washington e la vendita di armi a Kiev, che non sono state concesse o che richiedono la capacità di colpire in profondità all’interno della Russia. Oppure il suo ultimo tentativo di operare ancora una volta con una scadenza e vaghi avvertimenti: questa volta sono due settimane e, secondo quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti, entro tale termine deciderà cosa fare dell’Ucraina e della politica americana nei suoi confronti. In sostanza, se non ci saranno progressi verso un accordo di pace, o si raddoppierà la posta in gioco nel confronto con la Russia, alla maniera di Biden, oppure si abbandonerà questa guerra per procura terribilmente sbagliata a quegli europei troppo ostinati per rinunciarvi definitivamente.
Le recenti decisioni e azioni di Trump sembrano dimostrare che, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, gli Stati Uniti stanno effettivamente voltando pagina e abbandonando quel circolo vizioso di non apprendimento, per diventare un Paese con una curva di apprendimento più normale in materia di politica estera, proprio come la Russia. Possiamo solo sperare che prevalga questo atteggiamento più sensato, anche se l’Europa occidentale vuole rimanere indietro nel suo impotente regno fantastico di splendida onnipotenza.
Traduzione dall’inglese di Piero Cammerinesi per LiberoPensare
Tarik Cyril Amar, storico tedesco, lavora presso l’Università Koç di Istanbul e si occupa di Russia, Ucraina ed Europa dell’Est, di storia della Seconda guerra mondiale, di guerra fredda culturale e di politica della memoria.