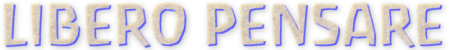di Andrea Zhok
Apparentemente il Comune di Roma avrebbe installato una macchinetta per lanciare le monetine nella Fontana di Trevi.
Si appoggia la carta di credito e taaac, la macchinetta spara al posto vostro la monetina nella fontana.
Che si tratti di una decisione amministrativa definitiva o solo di un test momentaneo, il gesto racchiude in sé l’essenza culturale di un’epoca destinata al macero nella memoria dei posteri (posteri che, ad occhio e croce, non saranno europei). Credo sia utile fare qualche considerazione di carattere generale prendendo spunto da questo trascurabile episodio.
La Fontana di Trevi è un monumento iconico di Roma, che compare in innumerevoli pellicole cinematografiche (La dolce vita, Tototruffa, C’eravamo tanto amati, ecc.) e che è oggetto di svariati usi, di cui il più noto è il lancio della monetina nella fontana. Questo lancio, fatto ad occhi chiusi volgendo le spalle al monumento propizierebbe un ritorno futuro nella città.
Questo tipo di costumi appartiene al novero amplissimo dei costumi propiziatori, ancora pagani, e poi ripresi in mille rivoli, sia nell’ambito delle religioni monoteiste sia come forme di superstizione magica.

Ora, è un dato di fatto che nel mondo delle credenze umane la sezione definita da conoscenze empiriche consolidate e prodotte secondo criteri scientifici rappresenta un’importante, ma piccola sezione di ciò che è creduto. Questa condizione è del tutto inevitabile. Anche in chi dedica la propria intera esistenza allo studio scientifico le proprie azioni sono necessariamente condotte solo in una minoranza di casi sulla base di ciò che è “scientificamente acclarato”.
E’ una buona strategia non prendere decisioni di interesse collettivo sulla base di credenze inadeguatamente fondate, tuttavia l’esistenza di queste credenze è parte dell’esistenza umana e rappresenta quella cornice di opzioni che lasciano aperte allo sguardo strade marginali, sentieri umbratili, percorsi alternativi, permettendo a mondi semplicemente possibili di farsi sentire – se e quando volessero farsi sentire.
Ciò che caratterizza l’autoritarismo positivista di cui è tacitamente imbevuto il progressismo contemporaneo (progressismo “di sinistra” come “di destra”, perché esistono entrambi) è la monodimensionalità della propria visione del mondo.
Questa monodimensionalità ha varie caratteristiche, ma la più rilevante in questo contesto è l’impostazione utilitarista, secondo cui ci sono fini (soggettivi, imperscrutabili) e poi ci sono mezzi separati per raggiungere quei fini.
La macchinetta sparamonete della fontana di Trevi è l’esemplificazione dell’incapacità mentale di una certo gruppo, sociale e culturale, di percepire la varietà di modulazioni delle credenze nel mondo.
La macchinetta vuole essere una “soluzione pragmatica” e vorrebbe essere anche “neutrale rispetto alle credenze soggettive altrui”.
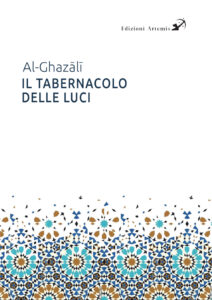
Solo che qui sfugge che ci sono fini che non sono separati dai mezzi, cose da fare che non sono separabili dal modo di farle, ci sono credenze per cui non ci può essere una “soluzione pragmatica”, perché in esse non c’è niente di pragmatico.
C’è l’evocativo, c’è il magico, c’è l’apotropaico, c’è la sfera delle possibilità umbratili, a metà strada tra il gioco e la metafisica, ma non c’è l’efficienza dei mezzi separata dalla soggettività dei fini.
Chi immagina che la forma della volontà umana sia quella di “collezioni di fini particolari” per cui si possono apparecchiare collezioni di mezzi adeguati semplicemente soffre di una cecità al senso.
Ma, si dirà, dopo tutto che problema c’è? Non la facciamo più grande di quello che è? D’accordo, sarà indice di cattivo gusto, ma in fondo è una sciocchezza.
Ecco, sì, naturalmente è una sciocchezza, ma è qualcosa di più di un indice di “cattivo gusto”.
E’ l’indice della stessa identica incapacità di comprendere culture, epoche o mentalità diverse dalla propria che rende il progressismo un’istanza autoritaria.
Si tratta di un autoritarismo inconsapevole, che si crede tutt’altro, si crede schietta ovvia verità, e proprio per questo motivo è particolarmente pericoloso.
Chi pensa che il mondo sia fatto di fini (soggettivi) e mezzi (oggettivi) non capisce e non capirà mai che talvolta, anzi per lo più, i modi di fare le cose sono la sostanza di ciò che si fa, la forma è la sostanza, il percorso è la meta, il costume è già il valore (e non un mezzo per il valore). E non capendolo, penserà che modi, forme, percorsi, tradizioni, costumi siano solo accidenti che possiamo liberamente sostituire con l’ultima astuta proposta delle coscienze illuminate.
 Andrea Zhok, nato a Trieste nel 1967, ha studiato presso le Università di Trieste, Milano, Vienna ed Essex. È dottore di ricerca dell’Università di Milano e Master of Philosophy dell’Università di Essex. Oltre a saggi ed articoli apparsi in Italia e all’estero, ha curato scritti di Simmel (Il segreto e la società segreta, 1992) e Scheler (Amore ed odio, 1993). È autore di Intersoggettività e fondamento in Max Scheler (La Nuova Italia, Firenze 1997), Fenomenologia e genealogia della verità (Jaca Book, Milano 1998), Introduzione alla “Filosofia della psicologia di L. Wittgenstein (1946-1951) (Unicopli, Milano 2000) e L’etica del metodo. Saggio su Ludwig Wittgenstein. (Mimesis, Milano 2001). Attualmente collabora all’attività didattica e di ricerca presso le cattedre di Filosofia della Storia e Filosofia Teoretica II dell’Università degli Studi di Milano.
Andrea Zhok, nato a Trieste nel 1967, ha studiato presso le Università di Trieste, Milano, Vienna ed Essex. È dottore di ricerca dell’Università di Milano e Master of Philosophy dell’Università di Essex. Oltre a saggi ed articoli apparsi in Italia e all’estero, ha curato scritti di Simmel (Il segreto e la società segreta, 1992) e Scheler (Amore ed odio, 1993). È autore di Intersoggettività e fondamento in Max Scheler (La Nuova Italia, Firenze 1997), Fenomenologia e genealogia della verità (Jaca Book, Milano 1998), Introduzione alla “Filosofia della psicologia di L. Wittgenstein (1946-1951) (Unicopli, Milano 2000) e L’etica del metodo. Saggio su Ludwig Wittgenstein. (Mimesis, Milano 2001). Attualmente collabora all’attività didattica e di ricerca presso le cattedre di Filosofia della Storia e Filosofia Teoretica II dell’Università degli Studi di Milano.