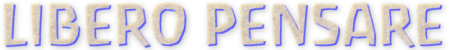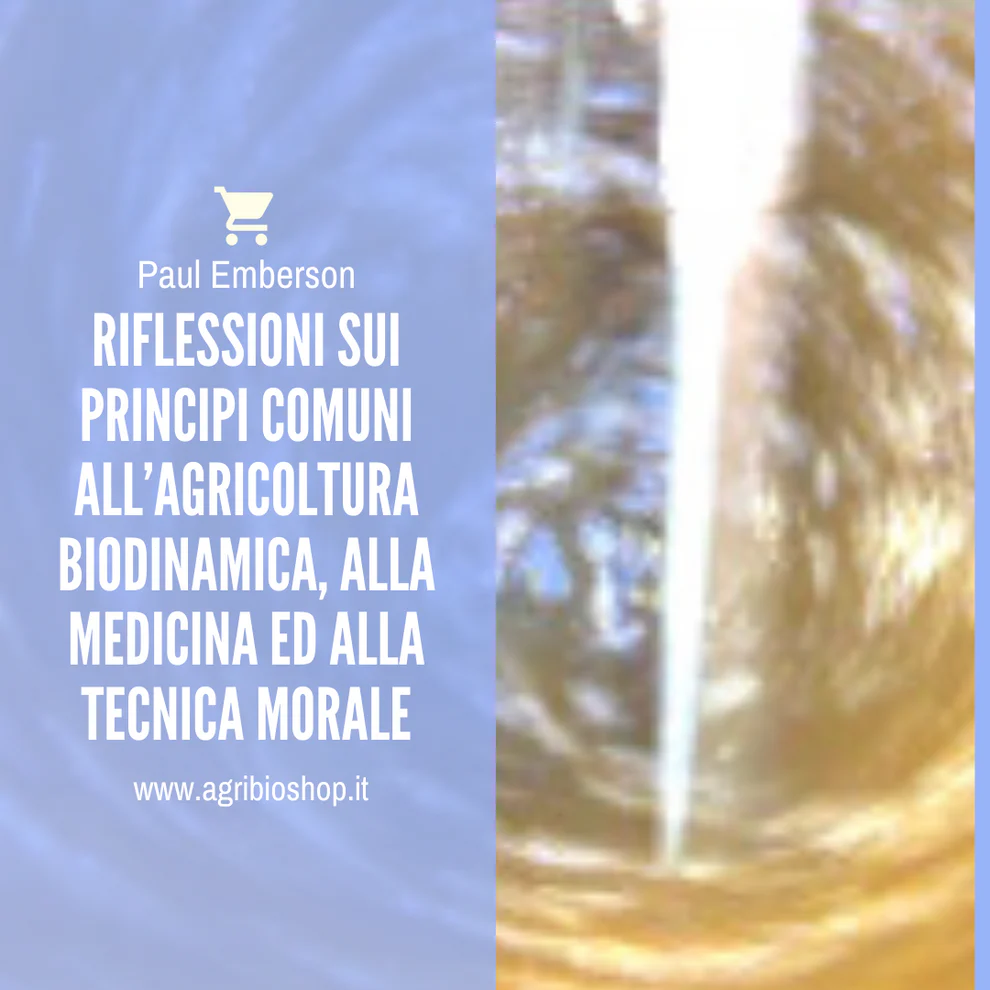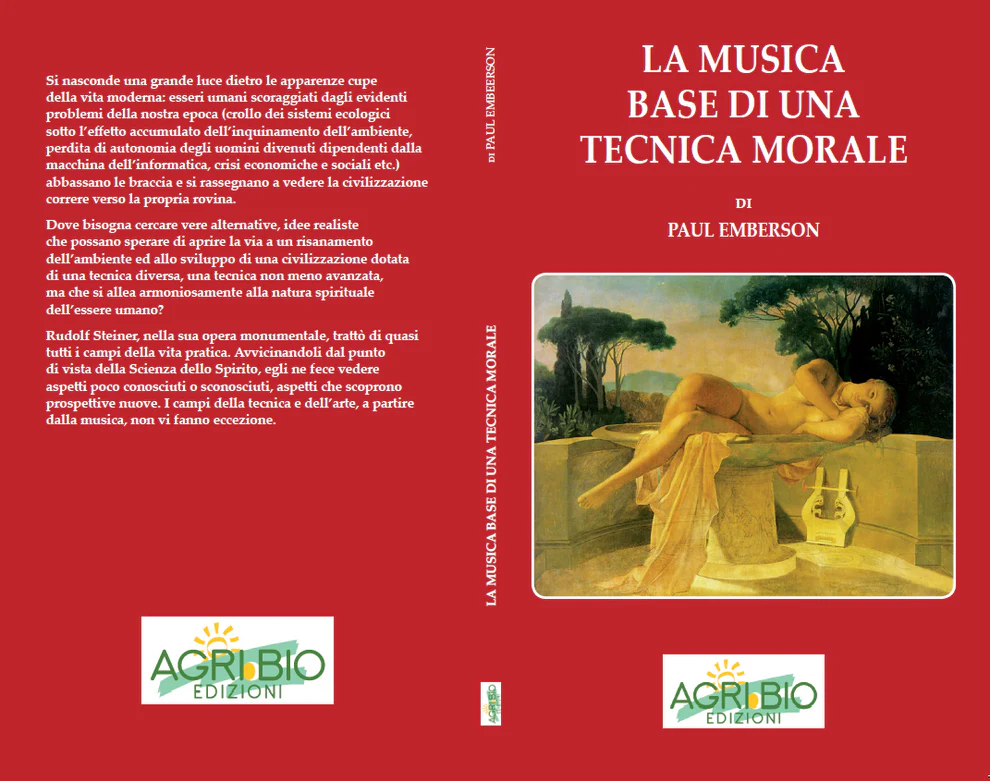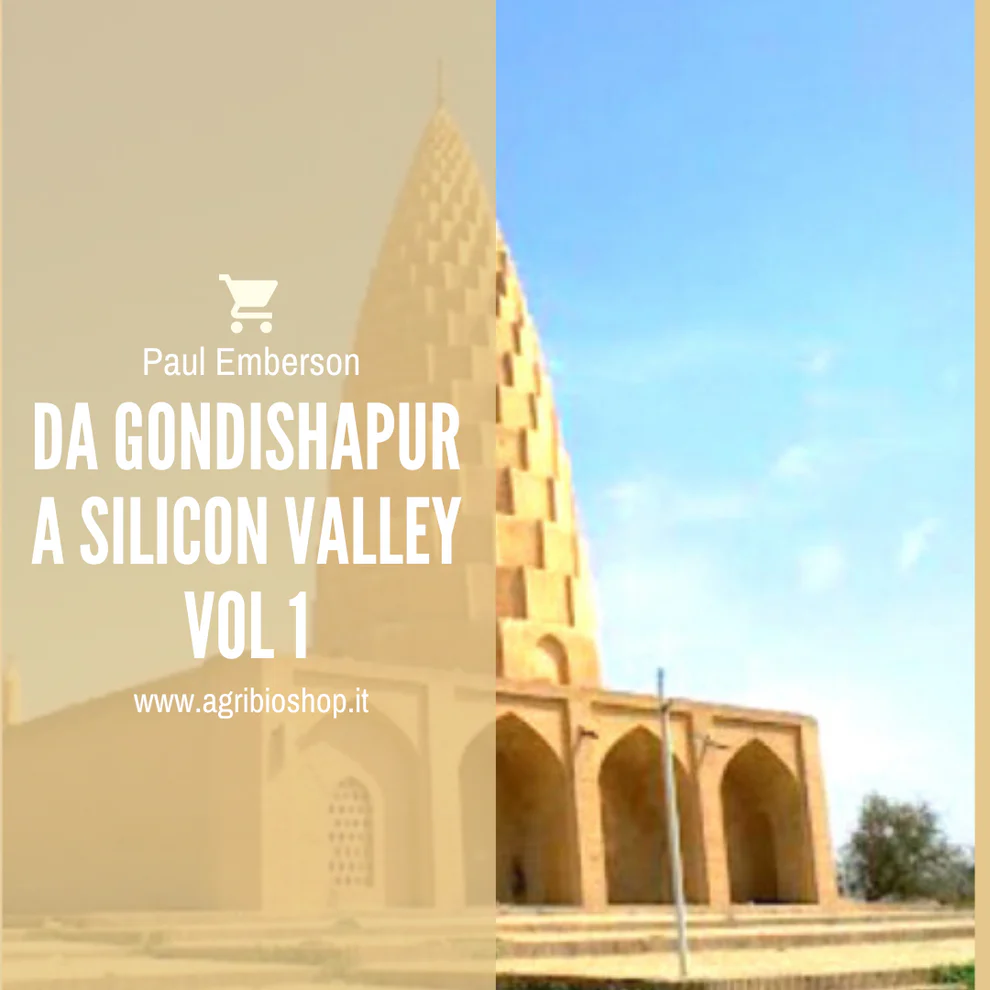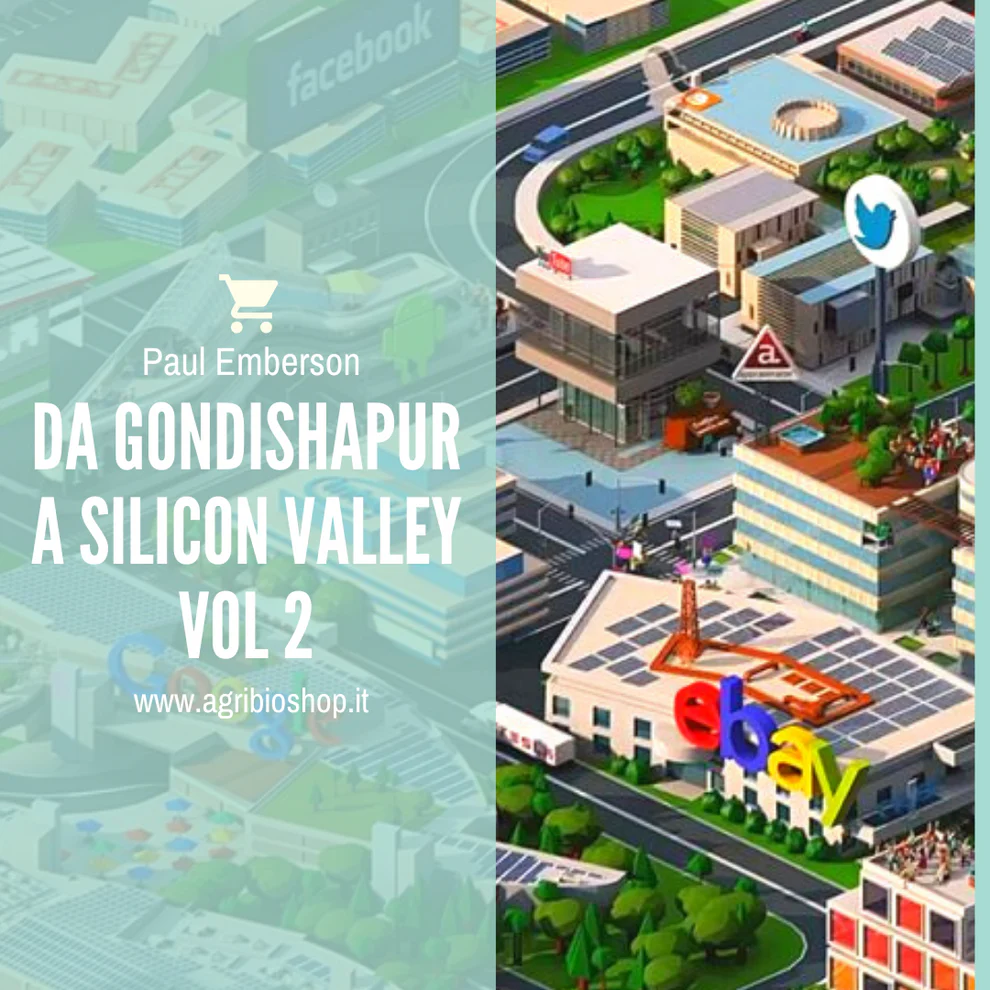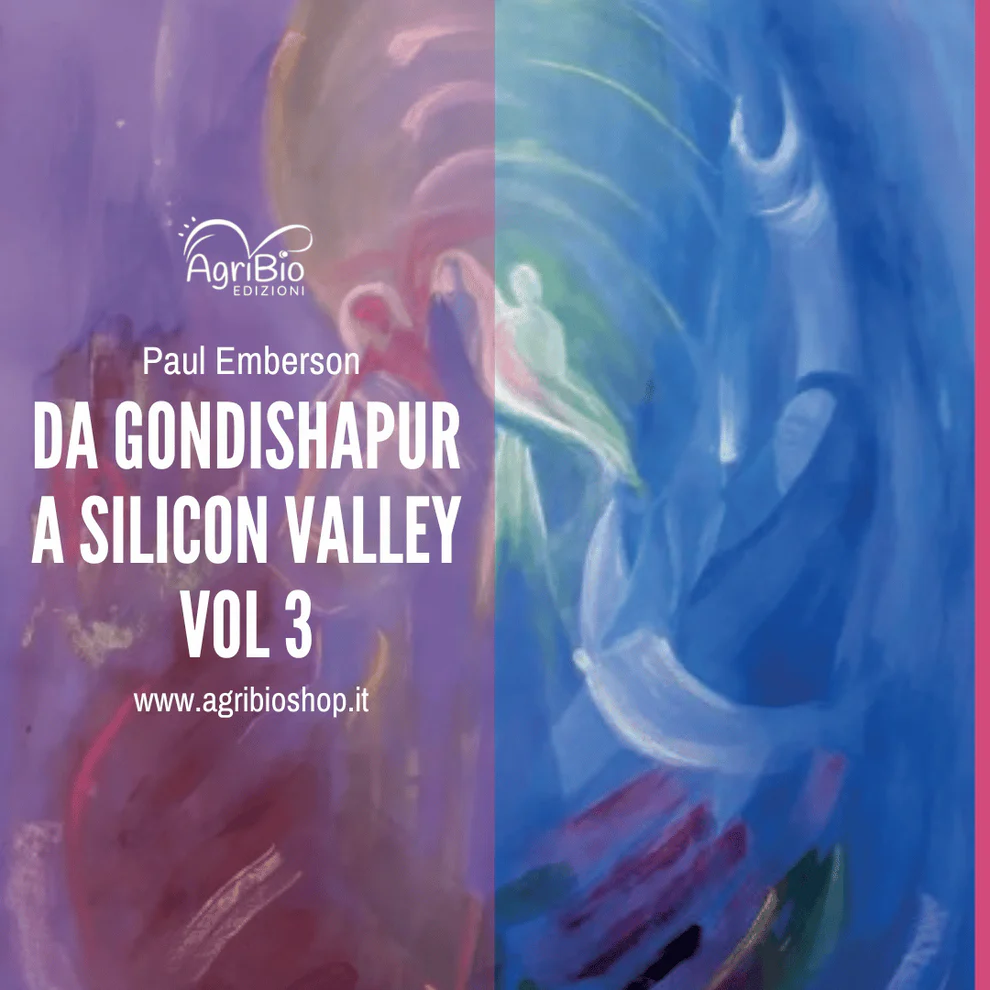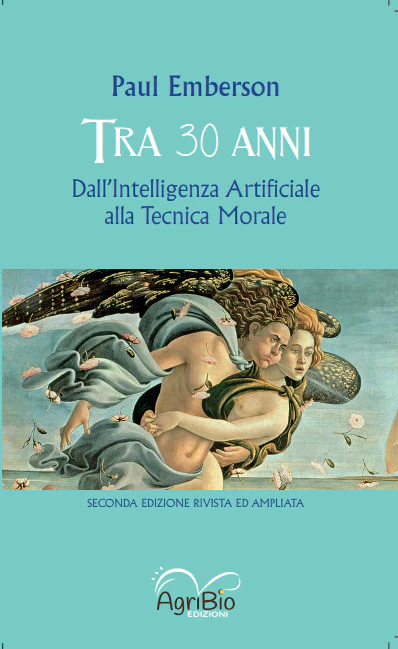di Sergio Motolese
Dalla schiavitù al lavoro liberato
E’ ancora possibile trasformare l’economia attuale e invertire la sua marcia distruttiva? Come bloccare questo processo degenerativo e farlo diventare il campo nel quale l’uomo sperimenti i suoi talenti per produrre ciò che è utile e necessario al vivere comunitario? Il cancro della finanza che domina sui processi produttivi può ancora essere estirpato prima che crisi economiche e guerre, che vediamo sempre più stagliarsi all’orizzonte, svolgano il loro ruolo inevitabile?
A ben riflettere, qualunque risposta si voglia dare a queste domande, il primo passo per ogni trasformazione è un radicale cambiamento di pensiero. Viceversa avverrà quello che è sinora avvenuto: cambiamenti fittizi, formali, parziali, utili a illudere, a dare qualche contentino e poter continuare il processo di asservimento delle coscienze a elite sempre più feroci e criminali.
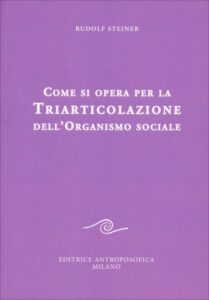
Tra i tanti possibili, un lembo da afferrare e dal quale partire per comprendere la portata rivoluzionaria della Triarticolazione Sociale proposta cento anni fa da Rudolf Steiner può essere il tema del lavoro, proprio quello che la Costituzione italiana pone a fondamento della Repubblica.
Ma cosa intendiamo oggi per lavoro?
“Nell’antichità c’erano gli schiavi. L’uomo intero veniva venduto al pari di una merce. Qualcosa di meno, ma pur sempre una parte dell’essere umano stesso, s’incorporava nel processo economico mediante la servitù della gleba. Il capitalismo è divenuto il potere che imprime ancora il carattere di merce a una parte dell’essere umano: all’energia del lavoro. (…) Del carattere di merce dato al lavoro umano, si fa una semplice questione economica, e si crede che dalla stessa vita economica debbano scaturire le forze che valgano a creare una condizione per la quale il proletario non possa più sentire come indegna di sé l’incorporazione della sua energia di lavoro entro l’organismo sociale. Si vede come la moderna forma dell’economia sia sorta nella vita storica dell’umanità. Si vede anche come questa forma dell’economia abbia impresso al lavoro umano il carattere di merce. Ma non si vede che è una caratteristica della vita economica stessa quella di dare il carattere di merce a tutto ciò che vi si incorpora. La vita economica consiste infatti nella produzione e nell’adeguato consumo di merci. Perciò non è possibile togliere al lavoro umano il carattere di merce, se non si trova la possibilità di svincolarlo dal processo economico.” ( R. Steiner: I punti essenziali della questione sociale – Ed. antroposofica)
“Il capitalismo è divenuto il potere che imprime ancora il carattere di merce a una parte dell’essere umano: all’energia del lavoro.”
Steiner scrive questo libro alla fine della Grande Guerra, quando il movimento proletario era in pieno fermento, esaltato dalla Rivoluzione di ottobre in Russia. Che poi l’economia altro non sappia e non possa fare che trasformare tutto in merce lo vediamo molto bene oggi, quando sono in vendita come merce preziosa cose impensabili sino a qualche decennio fa: le propensioni all’acquisto, i nostri movimenti fisici, battiti cardiaci, il numero dei passi, pensieri, emozioni e tutto ciò che la tecnologia digitale permette di controllare.
“Gli sforzi non devono essere diretti a trasformare il processo economico in modo che in esso venga difesa l’energia del lavoro umano, bensì a risolvere il problema: come riuscire a svincolare dal processo economico l’energia del lavoro, affinché essa venga regolata da altre forze sociali che le tolgano il carattere di merce?” (ibidem)
Ecco la prima provocazione al pensare.
E’ nella natura profonda del processo economico trasformare tutto in merce, è il suo compito occuparsi di produzione, commercio e consumo di merci. Come non tentiamo di trasformare un animale feroce in vegetariano ma cerchiamo di limitare i possibili danni che può causare all’uomo, così dobbiamo considerare il processo economico, senza distoglierlo dal suo compito, ma limitarne i danni che esso produce di necessità; uno di essi, il più significativo, è proprio l’asservimento dell’uomo al processo produttivo. Ecco perché dobbiamo “svincolare dal processo economico l’energia del lavoro”. Come?
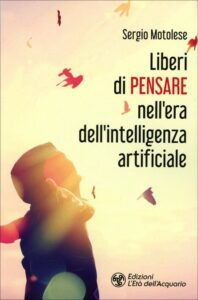
Quando Rudolf Steiner ha esposto in modo organico i principi della Triarticolazione Sociale, aveva già compiuto con la sua incessante attività un lavoro di semina durato più di 25 anni, fornito stimoli per educare il pensare, rendendolo tale da poter affrontare il capovolgimento di tutto quello sperimentato sino ad allora in campo sociale. Senza questo fondamento sarebbe stato difficile affrontare la complessità di pensiero che immaginare un organismo sociale triarticolato in tutte le sue declinazioni richiede.
Non si tratta infatti di “tripartire” la vita sociale in tre compartimenti stagni separati, come a volte viene erroneamente inteso; tanto meno si intende costituire tre Parlamenti. Triarticolare l’organismo sociale significa identificare in esso tre ambiti, tre sfere di attività, sapendo che l’unità la determina l’uomo, il quale agisce in tutti e tre, ma con modalità differenti in ciascuno di esse, e fare in modo che ciascun ambito sia ben identificato, ma non isolato, e riceva dagli altri due sia limiti che impulsi vitali al suo operare.
“Questo [l’organismo sociale], se vuole operare sanamente, deve sviluppare in sé tre strutture diverse, secondo le leggi che sono proprie a ciascuna.
Una di queste è la vita economica. (…) Attraverso la tecnica e il capitalismo essa è divenuta predominante in tutta la moderna società umana. La vita economica deve essere nell’organismo sociale una struttura relativamente autonoma, come lo è il sistema neuro-sensoriale nell’organismo umano. La vita economica comprende tutto ciò che riguarda la produzione, la circolazione e il consumo di merci.” (ibidem)
L’economia moderna è sempre più legata alla tecnologia digitale, la quale a sua volta trasforma processi umani in processi automatici. Il combinato disposto produce una struttura di puro potere, sempre più oppressiva e disumana verso gli altri ambiti della vita sociale, quello giuridico-politico e quello culturale-spirituale, e verso l’uomo stesso.
“Come seconda struttura dell’organismo sociale è da considerarsi la vita del diritto pubblico, la vita politica. [Essa] può abbracciare soltanto quel che sorge da sostrati puramente umani e riguarda i rapporti tra uomo e uomo. Nella vita si deve fare questa distinzione col sentimento affinché, come conseguenza, la vita economica si scinda da quella politica, come nell’organismo naturale dell’uomo l’attività dei polmoni per l’aspirazione e l’espirazione dell’aria esterna si scinde dai processi della vita neuro-sensoriale.
Come terza struttura (…) si ha da comprendere nell’organismo sociale (…) tutto quel che poggia sulle doti naturali del singolo individuo umano.” (ibidem)
Le istituzioni statali non vengono abolite ma vengono molto ridimensionate poiché cessano di gestire ambiti non di loro competenza, ovvero tutto ciò che attiene la vita economica, da un lato, e la vita culturale: scuola, scienza, arte, spiritualità, dall’altra. Una rivoluzione copernicana. Il lavoro, che ora ci interessa in modo particolare, è di stretta competenza proprio della sfera giuridica, in quanto attiene la dignità umana, non la produttività. Questa sfera è l’unica che emana norme che possono garantire l’eguaglianza tra le persone. In essa le decisioni sono prese a maggioranza.
Ma non basterebbe affidare alla sfera giuridica la regolamentazione del lavoro in tutti i suoi ambiti se anche la gestione dell’economia non subisse un cambiamento radicale. Essa dovrà essere gestita da Associazioni nelle quali siedono allo stesso tavolo produttori, distributori e consumatori. Qui non deve prevalere la maggioranza e neppure il “libero mercato” ma una vera concertazione, l’aspetto solidale, la fratellanza; la cosiddetta concorrenza lascia il posto alla determinazione di prezzi concertati di volta in volta secondo il luogo e le circostanze reali, prezzi che non penalizzano nessuno degli attori. L’imprenditore non possiede l’azienda ma la gestisce perché gli è affidata in base ai suoi talenti da un organismo esterno, che non appartiene alla sfera economica ma a quella culturale-spirituale.
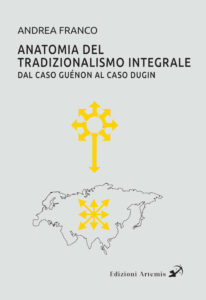
L’accenno che Steiner fa della triarticolazione dell’organismo umano ci fa comprendere come il centro sia sempre l’Uomo, la cui conoscenza ci aiuta a comprendere meglio la Società Organica Triarticolata. Ogni organismo vivente è tale quando al suo interno agiscono polarità contrapposte, e un terzo elemento che le armonizza di continuo. Nell’organismo umano il ricambio produce materia che viene distrutta dalla sfera neuro-sensoriale. Da questa distruzione di materia può nascere la coscienza, il sentire e il pensare. Il sistema ritmico, cuore e polmoni, equilibria il processo. Questo detto in estrema sintesi.
Anche l’Organismo Sociale è un essere vivente. L’attività economica distrugge di necessità, per sua stessa natura. Ci deve allora essere un altro organo che limiti i danni e ricostruisca ciò che viene distrutto per necessità: l’attività culturale, la scienza, l’arte, la scuola, tutta la libera attività culturale-spirituale dovrebbe servire a questo scopo. Nel caso specifico del lavoro, la sfera giuridica interviene dall’esterno di quella economica (di cui non si occupa) impedendo con norme di legge che la dignità dell’essere umano venga assoggettata alle esigenze produttive.
Già nel 1907, in un suo scritto (Scienza dello spirito e problema sociale), incluso nel libro citato sopra, Steiner così sintetizzava un principio fondamentale del vivere sociale:
“La salute di una comunità di uomini che lavorano insieme è tanto maggiore quanto meno il singolo ritiene per sé i ricavi delle sue prestazioni, vale a dire quanto più di tali ricavi egli dà ai suoi collaboratori, e quanto più i suoi bisogni non vengono soddisfatti dalle sue prestazioni, ma da quelle degli altri.”
Non è una astratta affermazione di principio o una aspirazione buonista, e neppure un invito ad un generico volontariato:
“Non si deve però pensare che basti dar valore a questa legge in un senso genericamente morale, oppure che la si voglia più o meno trasformare nel senso che ognuno lavori al servizio dei propri simili. No, in realtà la legge vive come deve soltanto se ad una comunità di uomini riesce di creare istituzioni tali che mai qualcuno possa trattenere per sé i frutti del suo lavoro, ma che questi vadano a vantaggio della comunità, possibilmente senza residui. In cambio ognuno deve a sua volta venir mantenuto dal lavoro dei suoi simili.”
E’ di tutta evidenza che non si tratta di calare concetti di questa portata pari pari nella realtà delle attuali istituzioni; sarebbe impossibile. Adesso è forse più chiaro il motivo per cui la risposta agli interrogativi esposti all’inizio richiede anzitutto una inversione totale di pensiero. Solo in una società triarticolata come quella esposta sono possibili contrappesi che si sorreggono reciprocamente; in quella attuale l’economia è un mostro divoratore che controlla governi, scienza e cultura. Se nell’organismo umano il sistema neuro-sensoriale avesse questo sopravvento, gli organi verrebbero uno ad uno distrutti.
Il capovolgimento di pensiero più significativo riguarda il fatto che il lavoro perderebbe sempre più il carattere “egoistico” (lavorare per guadagnare). La vita culturale, a partire da una scuola anch’essa liberata dalle grinfie del “mercato” e da quelle dei ministeri, formerebbe le persone non in base a esigenze produttive ma sviluppando in ciascuno i propri unici talenti da mettere al servizio della comunità. Il lavoro perderebbe allora il carattere costrittivo e assumerebbe sempre più quello creativo, e la famigerata “piena occupazione” sarebbe a portata di mano.
“ Il compito del presente è quello di portare gli uomini in una posizione tale che ogni singolo svolga il lavoro per la comunità movendo da un suo impulso interiore.” (ibidem)
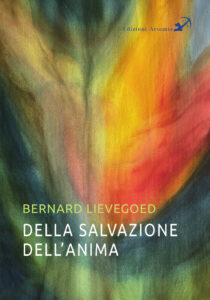
“Movendo da un suo impulso interiore.”
Esso non può scaturire in una società dominata dall’egoismo, in cui il darwinismo sociale tende a sopraffare in nome della “libera concorrenza”. A questi pensieri si possono fare decine e decine di obiezioni; essi possono essere anche derisi dai cosiddetti “pragmatici”, quelli che pretendono di guidare il mondo dopo averlo ridotto in questo stato. Essi non vedono la relazione tra le tragedie che ci circondano e l’organizzazione attuale del vivere sociale. Si fa fatica ad immaginare la portata rivoluzionaria che cambiamenti di questa natura produrrebbero.
Liberando il lavoro, trasformando le istituzioni attuali e riportando l’economia, vorrei dire costringendola, al suo ruolo e ambito originari, si produrrebbero a catena trasformazioni enormi non solo nel modo di vivere ma anche di pensare. Non una società perfetta, questa sì utopica, ma un organismo sociale vivo, in grado di evolvere in senso umano.
Vediamo già come tutto intorno a noi involva e il lavoro assuma forme sempre più disumane, quasi un ritorno a schiavitù antiche, mascherate da finta libertà, come nel caso dei riders. E che dire dei raccoglitori di pomodori a 3 euro l’ora? Sono i nuovi schiavi.
Non credo, ad esempio, sia utopia immaginare una Fondazione che riceva donazioni che permettano di affidare la gestione di una azienda agricola biodinamica a persone con i talenti per gestirla al servizio di una comunità. Costoro si possono avvalere di collaboratori, non di dipendenti, con i quali ripartire i ricavi, e non in parti uguali, secondo un astratto egualitarismo, e neppure secondo una piramide di importanza delle mansioni, ma secondo le esigenze dei singoli. Ecco un terreno per confronti umani evolutivi.
Le Comunità nuove, di cui ho parlato in altri scritti e di cui anche altri hanno scritto su Libero Pensare, possono cominciare a sperimentare questi principi, saggiarne le potenzialità e anche le difficoltà.
Non è semplice realizzare progetti di questo genere, perché bisogna remare sempre contro corrente e con venti e tempeste da evitare, ma forse gli scogli più ardui e pericolosi non sono quelli pratici, burocratici o gli interessi esterni che cercherebbero di ostacolare la riuscita, ma proprio il cambiamento dei nostri pensieri.
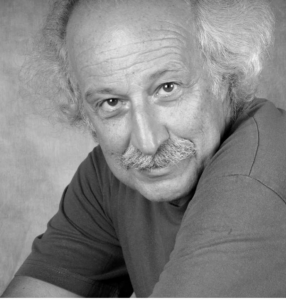 Sergio Motolese, musicista. L’incontro con l’antroposofia di Rudolf Steiner gli ha consentito di integrare le esperienze musicali con quelle acquisite in vari ambiti concernenti la salute.
Sergio Motolese, musicista. L’incontro con l’antroposofia di Rudolf Steiner gli ha consentito di integrare le esperienze musicali con quelle acquisite in vari ambiti concernenti la salute.
Negli ultimi anni si è occupato in particolar modo degli effetti del suono elettronico e dell’informatica digitalizzata sull’essere umano.
E’ diplomato presso la LUINA (Libera Università di Naturopatia Applicata). Tiene laboratori musicali, conferenze, incontri, seminari, gruppi di studio.