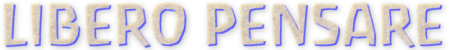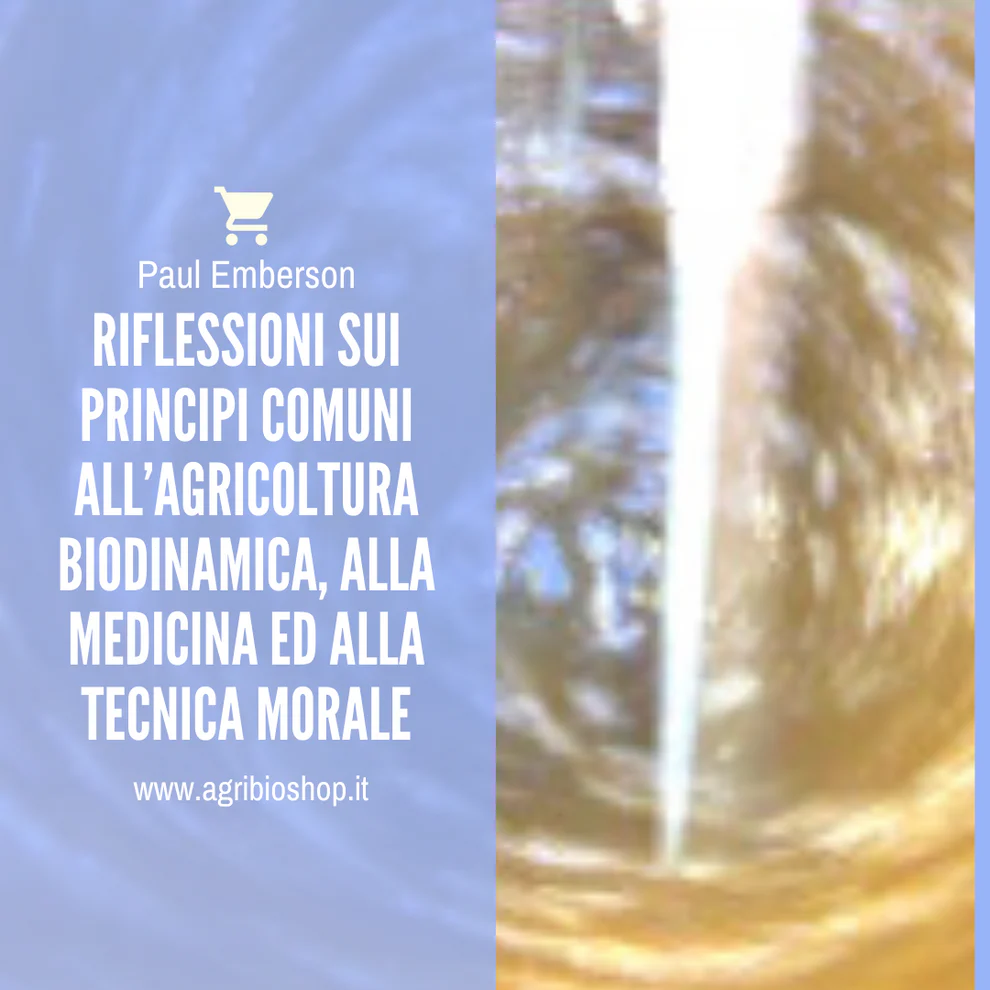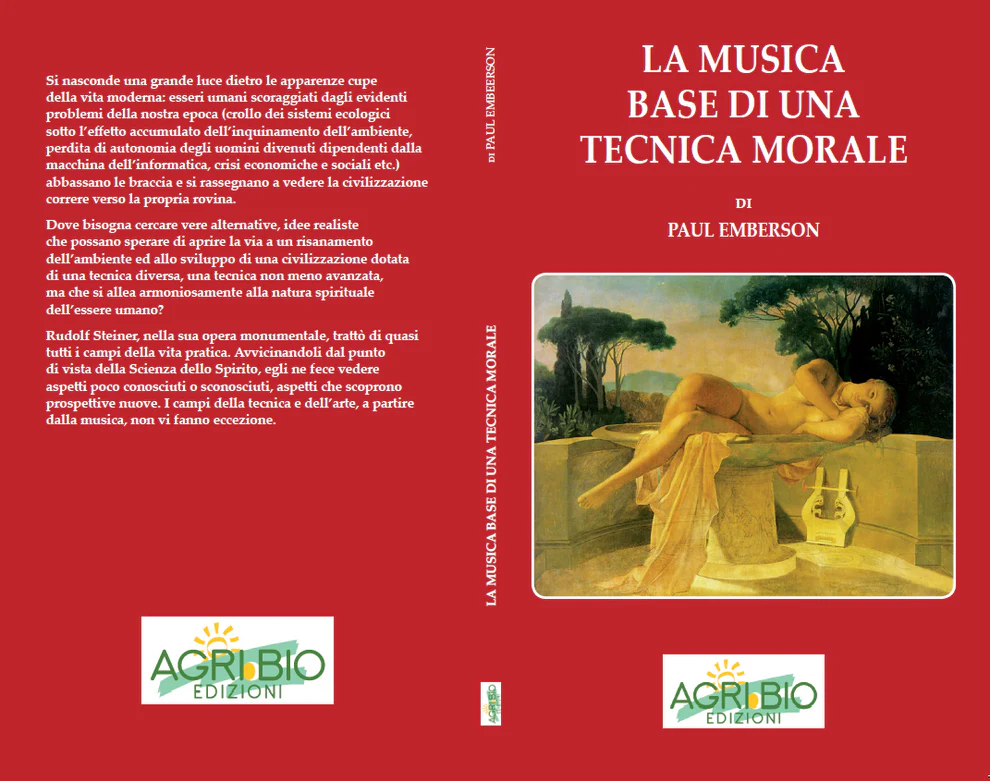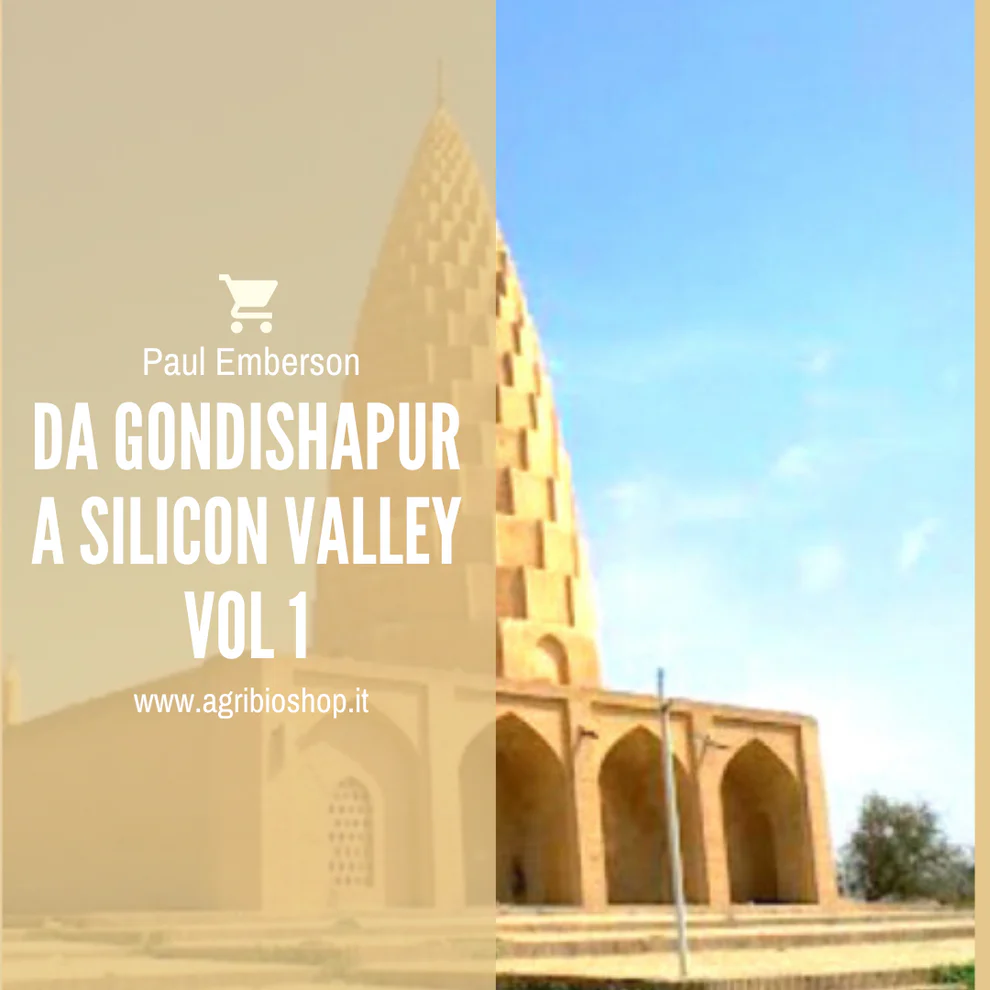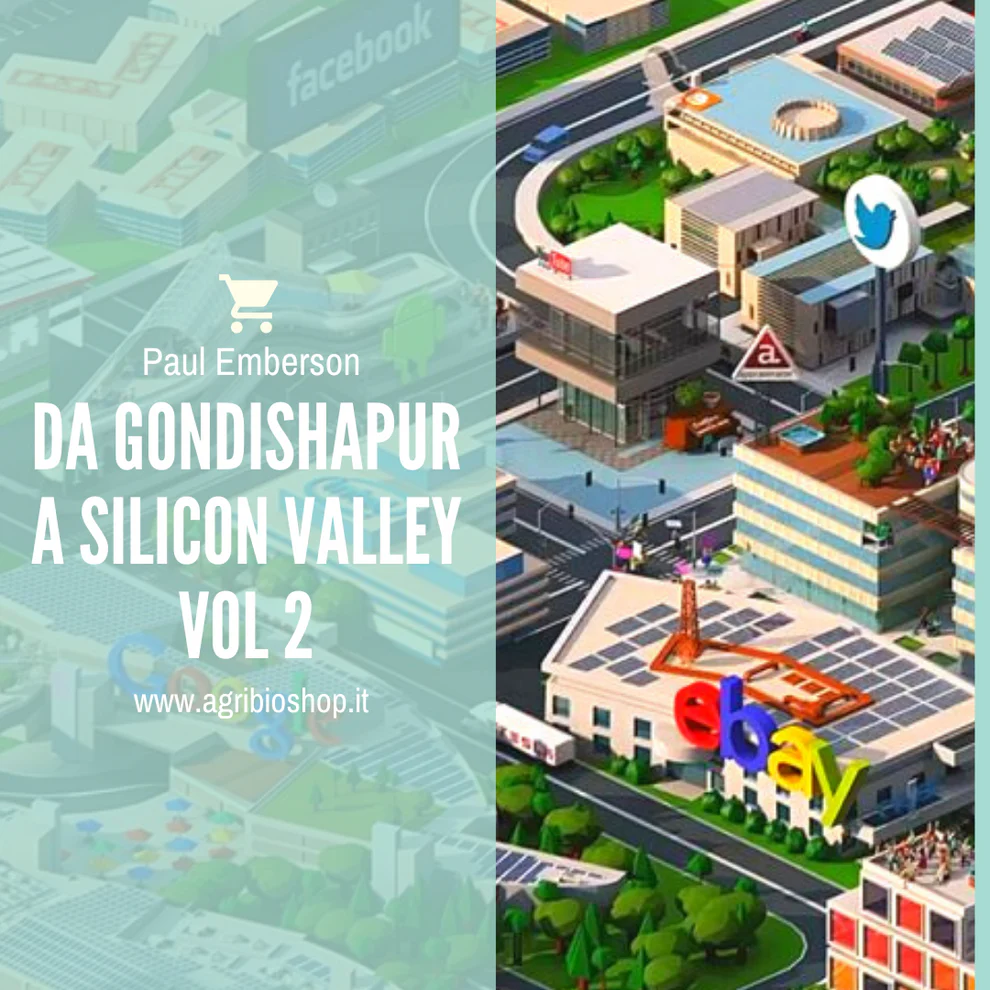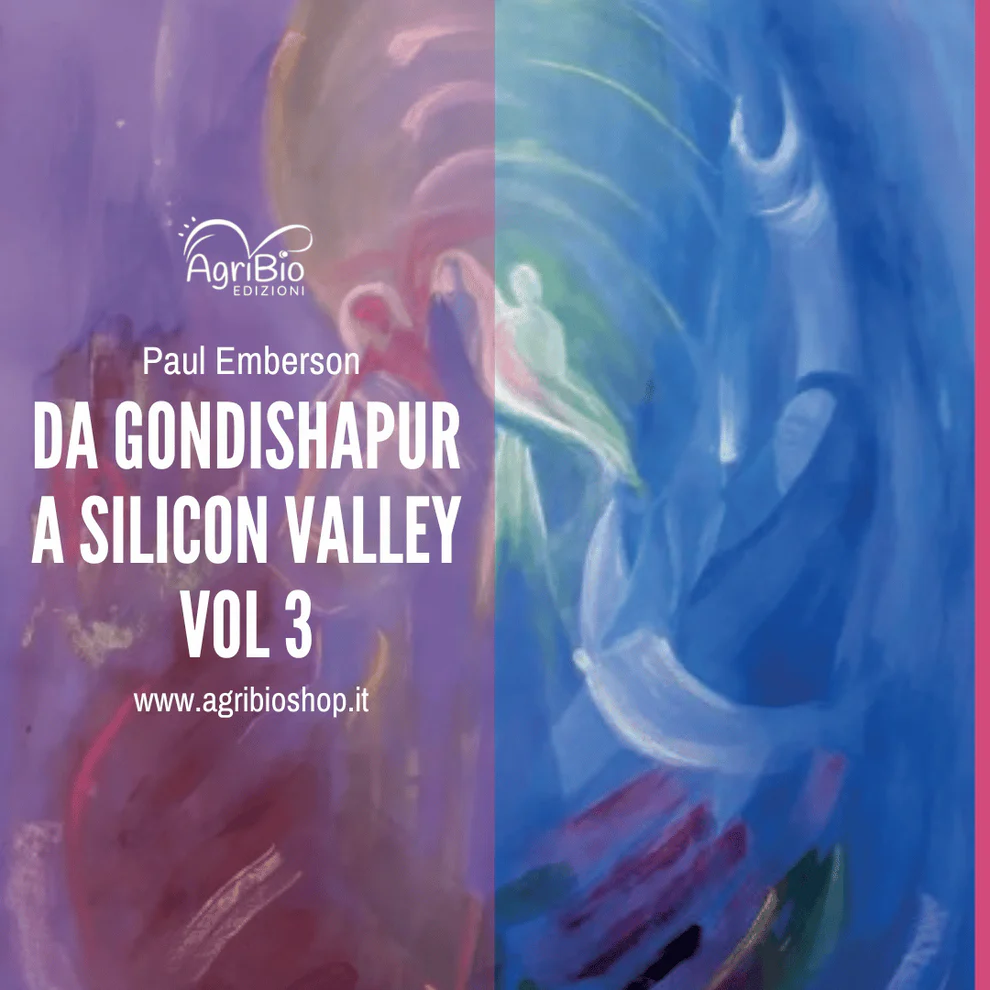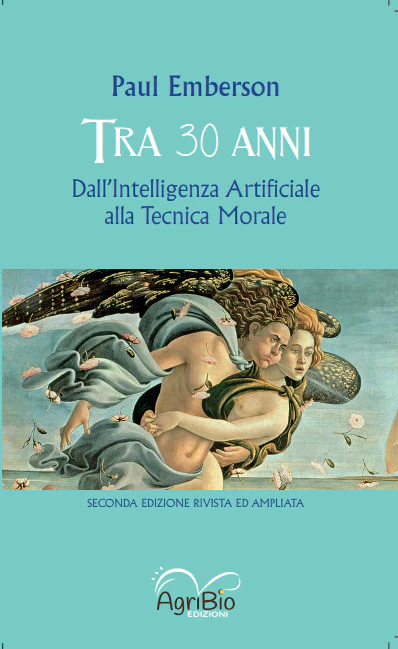1a Il XIX secolo aveva portato al mondo una serie di cambiamenti radicali, tanto che il secolo successivo era atteso con grandi aspettative. La scienza portò scoperte e invenzioni rivoluzionarie, l’orizzonte dell’esperienza e della conoscenza umana si ampliò a un ritmo sempre più rapido. L’economia iniziò a espandersi in tutto il mondo, le economie nazionali furono gradualmente sostituite da un’economia globale. La politica delle potenze dominanti portò in Europa al predominio delle varie potenze coloniali (Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Spagna, ecc.), all’unificazione italiana (1861) e alla formazione dell’Impero tedesco sotto la Prussia (1871), mentre l’Impero austro-ungarico e l’Impero russo ristagnavano e l’Impero ottomano andava gradualmente in declino. In America si assistette soprattutto al consolidamento degli Stati Uniti,¹ che consentì loro di diventare una potenza mondiale. Nei continenti africano e asiatico, invece, gran parte della popolazione viveva in condizioni di estrema povertà.
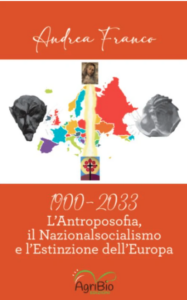
1b L’inizio del XX secolo sfociò politicamente nella prima guerra mondiale (1914-18), economicamente nella depressione degli anni ’20 e scientificamente, ad esempio, nella scoperta di Plutone (1930) o nella fissione nucleare (1937). E il nome Sarajevo divenne il simbolo del crollo dei vecchi ordini europei.² Cosa era successo?
1c La vita spirituale degli uomini non riusciva a tenere il passo con quella fisica e materiale, con la conseguenza che la vita animica si atrofizzò o si ritirò in se stessa. La filosofia, madre di tutte le scienze, non riusciva più a comprendere i suoi figli e si impoverì nel materialismo e nel positivismo. La teologia occidentale combatteva una battaglia difensiva dopo l’altra, non aveva quasi più accesso al Cristo come essere spirituale; i protestanti vedevano Gesù come un “semplice uomo di Nazareth” e il papato pensava di doversi salvare con il dogma dell’infallibilità (1870). Alcuni individui vedevano chiaramente l’imminente catastrofe,³ ma nessuna voce riusciva a farsi sentire in modo decisivo attraverso il clangore frenetico della civiltà moderna.
1d Rudolf Steiner nacque in questo periodo. Figlio di una semplice famiglia di ferrovieri, venne al mondo nel 1861 a Kraljevec e crebbe nell’Austria orientale. Lì assorbì tutto ciò che gli veniva offerto, inizialmente in modo un po’ sognante, l’incontro con la natura e la tecnica,⁴ la vita di campagna, le persone di lingue diverse (tedeschi, croati, cechi, ungheresi), poi in modo più consapevole la varietà della vita culturale viennese,⁵ i tumulti politici, l’interconnessione mondiale del commercio. Partecipò attivamente al dibattito culturale e politico del suo ambiente, sul quale già all’età di ventun anni pubblicò alcuni articoli.
1e Ben presto il giovane ambizioso fu invitato a pubblicare gli scritti scientifici di Goethe. Negli anni Novanta lavorò a Weimar, dove conobbe eminenti studiosi tedeschi. Successivamente si trasferì nella vivace Berlino di fine secolo, che osservò con occhio attento.⁶ Qui iniziò la sua vera e vasta influenza.
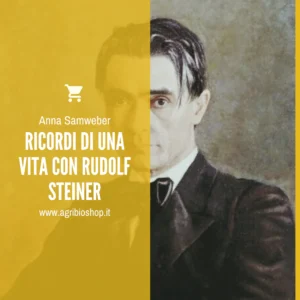
1f Oltre a questo mondo esterno, Steiner fin da piccolo ne conobbe un altro: un mondo ricco e variegato di immagini, accanto al quale quello esterno rischiava continuamente di sbiadire. All’inizio riusciva a comunicare solo con difficoltà questo aspetto interiore della sua esperienza, perché da un lato non disponeva di concetti adeguati per esprimere ciò che viveva, dall’altro sembrava che quasi nessuno fosse seriamente interessato, soprattutto quando il giovane Rudolf insisteva sulla realtà⁷ di quel mondo. Da parte sua, rifiutava sempre più la spiritualità che trovava, come il cristianesimo limitato al fisicamente comprensibile o la spiritualità confusa importata dall’Oriente; tali cose non potevano esistere davanti alla sua conoscenza. Decise di esplorare l’altro mondo con un approccio scientifico⁸, come aveva appreso dai suoi studi. Fu così che, a partire da quelle circostanze storiche, questa individualità pose le basi per una scienza dello spirito, che fu poi presentata e sviluppata a partire dal 1901.
1g Noi esseri umani del XXI secolo possiamo trovare nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner un mezzo per riconoscere anche le domande del nostro tempo e per affrontarle. Non sarà con idee obsolete o con un patrimonio spirituale ormai superato, e tanto meno con ideologie, che potremo resistere agli eventi del tempo, ma – e questo risulta sempre più evidente – solo con un contenuto essenziale⁹ elaborato da noi stessi e quindi reso vivo, di cui poi dovremo anche assumerci la responsabilità. L’antroposofia può offrire un aiuto concreto in questo senso.
Aggiunta
Da Dallo Yoga alla Rosa Croce di Massimo Scaligero
2a Trassi dunque dalla libreria La Scienza occulta, proprio per leggere qualcosa di semplice come una favoletta o un racconto sensazionale, dato che non avevo altro sotto mano. Aprii a caso il libro verso la metà e il mio occhio andò su una frase che immediatamente mi colpì: mi parve dirmi qualcosa di molto familiare: lessi e rilessi il periodo, lo meditai alquanto, e l’impressione di trovarmi dinanzi a qualcosa di essenziale gradualmente si accrebbe in me. Lessi ciò che veniva prima di quel punto e quello che veniva dopo, e mano a mano avevo la certezza di trovarmi dinanzi a quello che mi attendevo da tempo. Sulla scorta di UR, avevo bensì già letto e apprezzato volumi dello Steiner come Iniziazione e Coscienza d’iniziato, ma in quanto seguivo fedelmente Evola e Guénon, avevo accettato da questi autori una critica severa e riserve riguardo all’insegnamento dello Steiner. Da anni conosco serie di ricercatori che, in base a tale critica, hanno rifiutato l’Antroposofia di Rudolf Steiner: non conosco nessuno che, dopo aver accertato tale critica, abbia poi avuto la forza di ricredersi e di riconoscere nello Steiner, per “autonoma” revisione critica, qualcosa di più che un Maestro, il Maestro.¹°

2b Capii dunque d’un tratto che forse mi attendeva un lavoro nuovo di verifica dei valori sui quali mi ero sino ad allora appoggiato. Mi sprofondai nella lettura della Scienza occulta, per avere conferma di una precisa impressione interiore: di pagina in pagina cominciai a riconoscere il paesaggio a me familiare: da quella esposizione però balzava un significato, come la relazione interna, o l’essenza, che dava senso al tutto: era la relazione interna che io cercavo: la idea di cui la serie delle imagini era il linguaggio o l’alfabeto: e tale significato, nel libro medesimo, rimandava a un metodo di conoscenza, il contatto con il quale cominciò parimenti per mc a essere come un “riconoscere”, o un “ricordare”, qualcosa che già avevo realizzato con i miei mezzi, facendo dello yoga il mio yoga.
2c Ricordo che quel giorno, chiudendo il libro, ebbi per la prima volta l’idea che dietro la figura e l’opera di Rudolf Steiner si celasse lo personalità del Maestro che molti affannosamente cercano in Oriente o nei recessi della Tradizione. Mi trovavo dinanzi a una prova decisiva: lo Steiner rispondeva a interrogativi radicali dell’esperienza dell’anima, riguardo ai quali a me risultava per constatazione diretta non esservi conoscitori esoterici adeguati, né in Asia né in Europa. Della materia di cui io avevo tentato con i miei mezzi una penetrazione, giovandomi dei diversi insegnamenti, con appena affioranti risultati, egli era l’assoluto padrone: gli altri la ignoravano, anzi mostravano sprezzare per esempio quell’esperienza dell’“ètere” mentale, a cui lo Steiner connette il destarsi della coscienza imaginativa, e proprio in quanto egli nel parlare di tale esperienza talora si serve di termini ricorrenti nella moderna letteratura teosofica, tendevano a confondere questo suo insegnamento con i contenuti di quella letteratura.
2d In effetti a me risultava che di quel grado di coscienza poteva parlare con tanta sicurezza soltanto qualcuno che movesse con dimestichezza nella sfera di forze operanti a tale grado: a un livello invero superumano. Nel leggere le pagine dello Steiner, per me era chiaro che il problema di lui non era stato la penetrazione del Sovrasensibile, nel quale invero moveva come in un mondo familiare e al tempo stesso con autorità, bensì il mettere la descrizione di tale penetrazione in linguaggio accessibile al tipo umano il cui male endemico è l ‘intellettualismo.
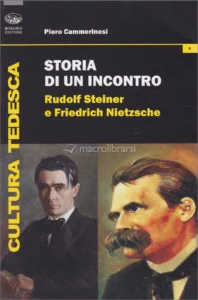
2e L’espressione dello Steiner mi risultava un sacrificio compiuto sul piano del linguaggio, non per brillare o persuadere mediante le parole, ma per aiutare il discepolo a superare la barriera delle parole, la dialettica. Mentre gli autori esoterici normalmente si riferiscono all’altrui esperienza sovrasensibile, o alla Tradizione, Steiner si riferisce alla propria esperienza. Gli altri comunque si appellano ai Maestri del passato, Egli invece si presenta come il Maestro: ma, appunto come dicevo, il più difficile ad accostare.
2f Nell’intento della fedeltà all’insegnamento di Rudolf Steiner, l’appartenenza al suo Movimento diviene reale, proprio grazie all’autonomia nel collegamento con la Società, che è in definitiva la forza della Società, essendo l’appartenenza l’atto interiore. Si possono tuttavia invocare norme, statuti, direttive, che giustamente esigano una determinata regolarità: occorre non dimenticare però che quelle norme sono espressione di un particolare periodo, dal quale è trascorso oltre mezzo secolo.
Note
1 Non senza schiavitù, sterminio degli indiani e guerra di secessione (1861-1865) – il Canada ottenne la piena autonomia solo nel 1931.
2 Oggi, alla fine di questo secolo, (cfr. Mbl.28) sembra essere tornato ad esserlo. In contrasto con gli sforzi di unificazione in Europa guidati dall’economia, la guerra civile in Bosnia ha avuto un effetto particolarmente crudo e ha portato alla prima insediamento di arabi islamici pronti a combattere.
3 Ad esempio Friedrich Nietzsche, Rosa Luxemburg o Oswald Spengler
4 Steiner viveva quotidianamente il mondo delle ferrovie a vapore, all’epoca il mezzo di trasporto più moderno, poiché suo padre era capostazione e viveva con la famiglia in una stazione ferroviaria.
5 cfr. TORBERG, F.: “Trattato sui caffè viennesi” in «Die Tante Jolesch»
6 cfr. Mbl-B.6
7 Livello degli effetti spirituali e mentali – La realtà (dal latino res, cosa) significa in senso stretto effettualità, non veridicità; tuttavia si può parlare di “fatti spirituali” e “realtà fisica”, perché i livelli dell’essere si compenetrano e si influenzano a vicenda.
8 cfr. Rudolf Steiner, Linee fondamentali di una gnoseologia della concezione goethiana del mondo.
9 ciò che attraverso il nostro essere autentico viene portato nel mondo in modo nuovo, fondamento di ogni “innovazione” e quindi in netto contrasto con le ideologie religiose, politiche o economiche
10 cfr. M. Scaligero per un approccio a Steiner
Bibliografia
STEINER, R.: «Mein Lebensgang» (La mia vita)
LINDENBERG, CH.: «Rudolf Steiner – Eine Chronik» (Rudolf Steiner – Una cronaca)
OSTERRIEDER, M.: «Die Welt im Umbruch» (Il mondo in trasformazione)
SCHMID, R.: «Rudolf Steiner»
WEHR, G.: «Rudolf Steiner»
W.G.VÖGELE: «Der andere Rudolf Steiner» (L’altro Rudolf Steiner)
WIKIPEDIA: Rudolf Steiner
Tradotto dal tedesco da Piero Cammerinesi per LiberoPensare